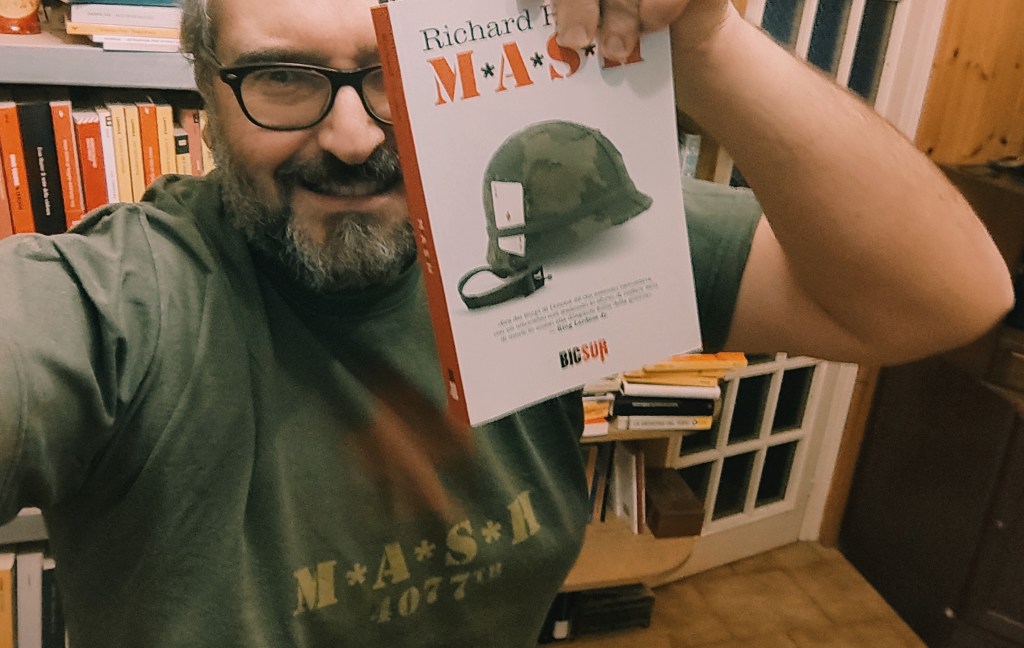Il personaggio di Dexter Morgan nasce nel 2004 dalla penna di Jeff Lindsay. Con il romanzo Darkly Dreaming Dexter, tradotto in italiano prima come La mano sinistra di Dio e successivamente come Dexter il vendicatore, Lindsay ha vinto il premio Dilys per la letteratura poliziesca, ma non solo. Ha dato vita a uno dei personaggi più emblematici della serialità degli ultimi vent’anni. Quando Dexter sbarca in tv, già dopo la prima stagione del serial, la vita del personaggio televisivo e quella del personaggio letterario si divideranno e successivamente romanzi e serie televisiva narreranno vicende non più correlate. Si tratta di uno di quei rari casi in cui la trasposizione televisiva è forse migliore dell’originale letterario (ho letto quattro romanzi sui cinque che ho acquistato e mi ricordo ben poco), grande merito quindi a papà Lindsay per l’idea geniale, ma anche un sentito ringraziamento ai produttori e agli sceneggiatori che tanto hanno saputo inventare e sviluppare lo spunto iniziale (in particolare all’ideatore della serie James Manos Jr. e a Clyde Phillis, showrunner delle prime stagioni e dell’ultima, appena conclusasi, Dexter: New Blood).

Per chi non lo sapesse, chi è Dexter? È un tecnico della scientifica di Miami, interpretato da Michael C. Hall, che si occupa di analizzare scene del crimine (in particolare schizzi di sangue). Nel suo stesso dipartimento lavora anche sua sorellastra Debra (Jennifer Carpenter, ex moglie di Hall nella vita), che all’inizio della storia è un’aspirante detective, poi in seguito lo diventerà. Questo per quello che riguarda la vita alla luce del sole di Dexter, il quale nasconde infatti un lato oscuro che nessuno conosce e che si riallaccia anche al momento della sua adozione. Da piccolo venne salvato da un poliziotto, il padre di Debra, sulla scena dell’uccisione di sua madre, in un letterale bagno di sangue. Harry Morgan (che ha il volto di James Remar) decise di adottarlo e di prendersi cura di lui, anche e soprattutto quando iniziò a notare nel ragazzo inquietanti istinti omicidi. Invece di farlo rinchiudere o di denunciarlo, Harry educò Dexter a seguire un codice attraverso il quale tenere a bada il Passeggero Oscuro, ossia l’insopprimibile desiderio di uccidere. Prima regola, non farsi mai catturare, seconda regola, uccidere solo chi se lo merita ed esserne assolutamente certi. Già dalla prima stagione Harry compare solo nei flashback o come una sorta di voce guida che consiglia a Dexter come comportarsi. La storia quindi è questa: Dexter compie indagini parallele a quelle della polizia e ogni volta che riesce a raccogliere prove convincenti sulla colpevolezza di un criminale che la giustizia non riesce a condannare, entra in azione. Come ogni serial killer, ha un suo rituale, che segue ogni volta maniacalmente.
Come insegnano quelli bravi, una storia non può procedere se manca il conflitto ed è inevitabile che non tutto fili liscio come dovrebbe. Presumo che chi abbia già visto sappia che cosa intendo e chi si accosta ora a questa serie, sia ben lieto di scoprire le cose, senza che qualcuno gliele racconti prima. Sta di fatto che la storia procede e Dexter, pur non provando sentimenti come un essere umano (l’uso della voce fuori campo è da manuale, spiega, aggiunge, ma non massacra lo spettatore di infodump) alla fine si sposa e ha un figlio, Harrison. Una delle sue più grandi preoccupazioni diventerà quindi capire se il ragazzo ha ereditato qualcosa di malvagio da lui o se riuscirà a condurre una vita tranquilla. La serie regolare è andata in onda per otto stagioni. In Italia è rimasta quasi sempre su canali a pagamento, tipo Fox Crime e quando è stata trasmessa in chiaro (su Rai4 e Cielo) veniva mandata a orari bulgari, anche perché c’è poco da censurare, o la tieni com’è in toto o la tagli tutta (bello sto gioco di parole parlando di un serial killer che fa a pezzi i corpi delle sue vittime e li fa sparire in fondo al mare). Siamo pur sempre nel Paese di Don Matteo e, anche se i toni di Dexter non sono sempre cupi, anzi spesso e volentieri c’è molta ironia, un personaggio del genere forse è considerato ancora un po’ troppo estremo, per i messaggi che potrebbe veicolare. Discorso complesso, che non vorrei affrontare ora, ma è per questo che esistono i programmi vietati ai minori. È un mistero, ad esempio, ma forse è solo un problema mio, che senso possa avere continuare a mandare in onda nel preserale la versione edulcorata di CSI, ma lasciamo stare. Dexter è un’altra cosa e molto probabilmente spaventa più dal punto di vista etico piuttosto che per le scene di violenza e sangue.
Nel cast della serie nomi di pregio e qualche guest star di alto livello: Julie Benz (Rita, la moglie di Dexter), Lauren Vèlez, Erik King, David Zayas, Keith Carradine ( l’agente speciale della FBI Lundy), Jimmy Smit (il procuratore Prado), Jesse Borrego (che cito solo perché era nel cast del telefilm Saranno famosi nella parte di Jesse Velaquez), John Lithgow (il miglior antagonista di Dexter, secondo me, ossia Trinity), Julia Stiles (Lumen), Johnathan Lee Miller (che fu Sick Boy in Trainspotting), Peter Weller (l’ex Robocop è un ex agente di polizia non del tutto pulito), Colin Hanks (figlio di Tom), Edward James Olmos (Blade Runner, Miami Vice), Ray Stevenson, Charlotte Rampling e Yvonne Strahovski, che interpreta Hannah McKay, ultimo grande amore di Dexter.
Quindi, dopo otto stagioni di ammazzamenti, sotterfugi, vita familiare fintamente serena e molte simili amenità, che non vado a riassumere, il finale dell’ultima stagione ha deluso in modo clamoroso tutti i fan. Dexter affida suo figlio alla donna che ama, Hannah, ma se ne va da solo, fingendosi morto e lo si vede in un altro contesto, lontano da Miami, triste e contrito, senza più nessuna voce che gli parli.
Era il 2013 e dopo tutti questi anni ci eravamo messi l’anima in pace, se così si può dire.
Nel 2021 invece arriva da Showtime la notizia bomba del tutto inattesa : una miniserie revival su Dexter era in fase di produzione. Hype alle stelle. Che cosa c’era da aspettarsi? Sarebbe stato un degno finale stavolta?
Così arriviamo a Dexter: New Blood. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa dal mondo e Dexter si è rifatto una vita in un freddo paesino dello stato di New York, che si chiama Iron Lake. Ha un lavoro presso un’armeria (la caccia è molto in voga in zona, ma lasciate stare i cervi bianchi, per favore), è fidanzato con Angela, capo della polizia, e vive tranquillamente sotto il nome di Jim Lindsay (un cognome a caso, eh?). Tutto bene, quindi? Non esattamente. A parte il fatto che nel paese c’è un buon tasso di teste calde, da anni in zona si ripetono misteriose sparizioni di ragazze, che di solito sono sole e in viaggio, di passaggio attraverso Iron Lake. E poi all’improvviso Jim trova in casa un intruso, un ragazzo che dice di essere suo figlio, Harrison. La prima cosa che mi ha fatto pensare che fossimo di fronte a qualcosa di diverso è il fatto che mancasse la sigla iniziale e a pensarci bene non avrebbe avuto senso riproporla. Dexter è cresciuto, la sua routine di vita è cambiata, ora è come un ex tossico o un ex alcolizzato (questo mi è stato fatto notare e l’intelligente osservazione che ne consegue la faccio mia) e come tale, appena sfiora qualcosa che potrebbe riportarlo alla dipendenza, ci casca dentro con tutte le scarpe. La storia inizia lenta, crea dei presupposti per quello che verrà, e l’unica cosa che avviene velocemente è il ritorno di Dexter all’omicidio, anche se, in realtà, ci saranno meno ammazzamenti del solito. Ma in questo svolgersi, che all’inizio pare macchinoso, della trama, non c’è da dimenticarsi di quello che è stato. Si riparte, ma non da zero. I vecchi fantasmi, i sensi di colpa per le tragedie provocate direttamente o indirettamente dal nostro eroe in passato, sono sempre lì, gravano su ogni scelta, su ogni singola azione. Specialmente adesso che è riapparso Harrison e non risulta facile relazionarsi con lui. Il ragazzo è ovviamente problematico, e non potrebbe essere altrimenti, visto quello che ha passato fin da piccolo. Il punto di svolta si ha quando si fa assoluta chiarezza su chi sia il cattivo da fermare (interpretato da un bravissimo Clancy Brown, che fu il terribile Kurgan nel primo Highlander, visto di recente anche in Billions) e Dexter si confida con Harrison. Il cast è composto anche da Jack Alcott nella parte di Harrison e Julia Jones nella parte di Angela Bishop.
Ecco, non direi altro, se non proporre due osservazioni.
Si capisce subito che tra i due serial killer non c’è gara, Dexter è troppo skillato, l’antagonista lo riconosce e si difende come può, con altri mezzi, sotterfugi e colpi bassi. I due si riconoscono, si annusano, si prendono le misure a distanza come due pugili prima di darsele di santa ragione, ma, appunto, è abbastanza chiaro chi prevarrà nel corpo a corpo. La seconda osservazione è sul finale. Infatti non c’è solo la sfida tra i due killer, ma tutto quanto sviluppato fino a quel punto trova una sua evoluzione e un esito che, se non si può considerare inevitabile, è se non altro giusto e coerente. Giusto non nel senso morale del termine e non nel senso che vada tutto a posto come in un vissero felici e contenti qualsiasi, non siamo in una fiaba. Ho letto e visto recensioni di gente che evidentemente queste cose non le ha capite e si è limitata a denigrare questa scelta, anche se forte, più che plausibile. Perché scrivere un finale è sì operare una scelta, ma tale scelta deve crescere e fiorire organicamente da quanto si è raccontato fin lì. Poteva finire in un altro modo? Sì, forse. E da fan sono il primo a dire che sarebbe bello che certe storie non finissero mai, ma la scelta, appunto, è se narrare una storia che si ripete uguale all’infinito o se raccontare qualcosa di più verosimile, nel limite del possibile. Questo solo per dire che ho preferito questo finale al precedente, senza ombra di dubbio.
La miniserie in 10 episodi, come credo la serie storica, è presente su Now Tv e aver scritto tutta sta pappardella mi fa venir voglia di un re-watch totale globale. Finirà tutto qui? Non è detto. Sia su Sky (e Now Tv) che su Showtime la serie ha avuto ascolti da record (tra visioni in diretta e on demand), tanto che alla casa di produzione stanno seriamente valutando se darle un seguito.
Chi vivrà, vedrà.