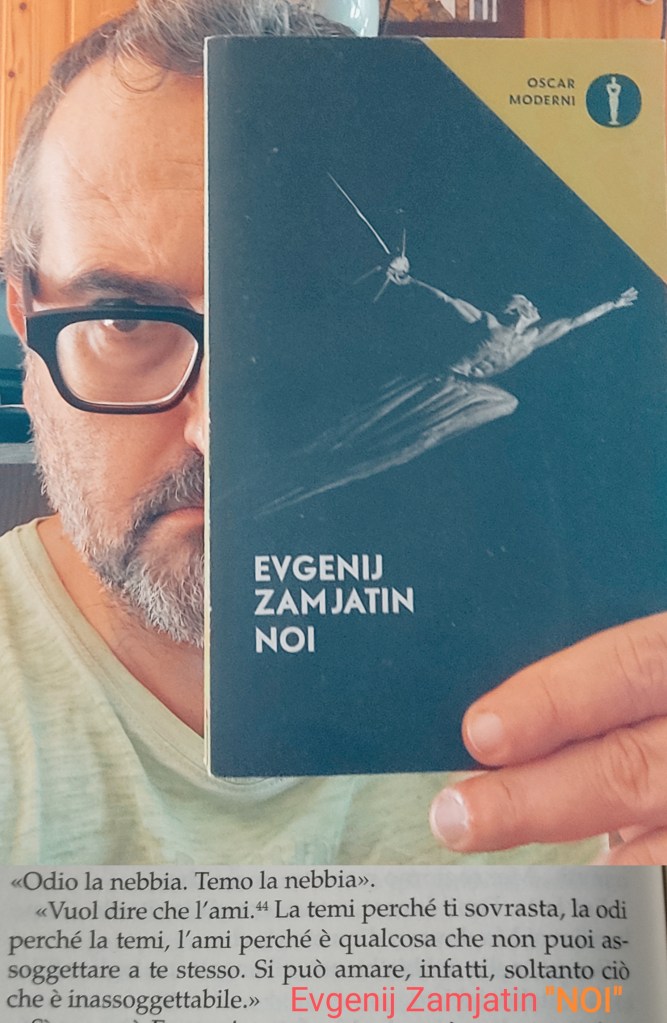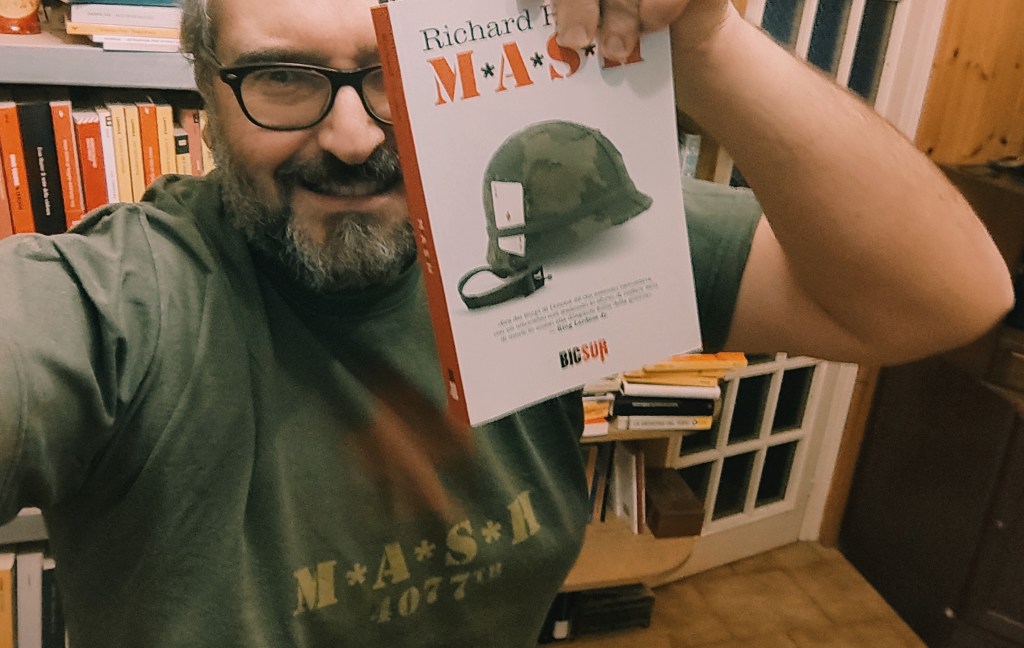L’acclamata serie di James Gunn che parla di questo controverso super eroe è sbarcata in Italia. L’ho vista ed ecco che cosa ne penso.

Da quando James Gunn ha assunto un ruolo decisionale all’interno dell’universo cinematografico della DC, molti sono stati i rumors riguardo ai nuovi sviluppi e/o ai reboot di vari personaggi. Ci sarà probabilmente un nuovo Superman che non avrà il volto di Henry Cavill (sigh!), il giovane Batman dell’accoppiata vincente Reeves-Pattinson avrà di sicuro un seguito, ma non si esclude che ci sarà anche un cavaliere oscuro più “anziano”, che già dovremmo vedere nel film dedicato Flash, in uscita prevista a giugno di quest’anno, (Michael Keaton, ma forse anche Ben Affleck). Meno chiari sembrano i destini di Wonder Woman (si farà il terzo film? e con quale attrice?) e di Aquaman (dovrebbe uscire Aquaman 2, ma a questo punto farebbe parte del vecchio universo), considerato anche il fatto che Jason Momoa potrebbe assumere il nuovo ruolo di Lobo (Hype!).
Fatte queste debite considerazioni non si può negare che Gunn sia tra i migliori sceneggiatori e registi di cinecomic, se non il migliore in assoluto, attualmente. Il che non è qualcosa di banale, tenendo conto di alcuni fattori. Come va scritto un cinecomic convincente oggi? A chi si deve rivolgere?
Il pubblico è ormai sgamatissimo e abituato a qualsiasi cosa. È una mera illusione sperare di stupire con effetti speciali (come recitava un vecchio spot pubblicitario) o con trame banali in cui il bene sconfigge il male, tanto per rimanere nel più facile dei cliché. Bisognerebbe dosare correttamente ironia e tragicità, creare personaggi interessanti, pieni di sfaccettature, di motivazioni, di conflitti interiori e attorniati da comprimari credibili, in un ambiente che non sembri un plastico o un presepio.
Ho detto poco, eh?
Si tratta in parole povere di saper giocare con la sospensione dell’incredulità dello spettatore, raccontargli il fantastico e l’incredibile, ma facendoglielo “digerire” come verosimile. Semplificando molto la questione, parecchi film Marvel spesso peccano di troppa leggerezza, esagerando con battute comiche fuori luogo in momenti drammatici e amenità varie; al contrario alcune pellicole targate DC sono state tacciate di essere troppo cupe e seriose. Gunn, che ha lavorato per entrambe le case di produzione, ha dimostrato a più riprese di saper amalgamare in modo convincente gli elementi necessari per dar vita a prodotti avvincenti, che possano venire agevolmente fruiti anche in più chiavi e a più livelli di lettura (e così mi smarco anche dalla questione target, che di per sé meriterebbe molti approfondimenti).
La serie de I Guardiani della Galassia (quest’anno è prevista l’uscita del terzo film) ne è una prova lampante (Marvel), come lo è stato The Suicide Squad – Missione Suicida (DC).
Quest’ultimo, pur essendo stato un flop al botteghino, ha riscosso molte reazioni positive dalla critica e da un certo pubblico (non quello delle sale, evidentemente). Una banda di anti eroi o super eroi minori, che hanno pendenze con lo Stato, viene assoldata da Amanda Waller (personaggio ricorrente nei film DC, interpretata da Viola Davis), agente governativa esperta in operazioni segretissime, per una missione potenzialmente suicida, appunto, con la promessa di ottenere qualcosa in cambio, riabilitazione o altro. Ne fanno parte Bloodsport, un arsenale da guerra umano, interpretato da Idris Elba, Harley Quinn, che per la terza volta (dopo i poco riusciti Suicide Squad e Birds of Prey) ha il volto di Margot Robbie, King Shark, un gigantesco squalo antropomorfo, che sa a malapena parlare e che nella versione originale è doppiato da Sylvestrer Stallone e, tra gli altri, da Christopher Smith, nome di battaglia Peacemaker (interpretato da John Cena), uno psicopatico un po’ razzista e misogino, con un costume dalla maglia rosso acceso, pantaloni bianchi ed elmetto dalle strabilianti funzioni, abilissimo con le armi e abilissimo anche a dire la battuta sbagliata nel momento sbagliatissimo. Unico suo scopo: la pace. Genericamente, tipo che se qualcuno del livello della Waller gli ordina di fare qualcosa “per la pace”, lui lo fa, anche se comporta qualsiasi atto criminoso, omicidio incluso. Nel film, Peacemaker non ne esce benissimo, tradisce in qualche modo il gruppo e si macchia di un omicidio, ma poi ne paga le conseguenze.
Nel 2022 James Gunn decide di dedicare a lui la serie spin-off del film, The Peacemaker, uscita negli Usa a gennaio e approdata da noi a fine dicembre (su Tim Vision). Un successo, ma come è possibile, dato che il protagonista ha molti tratti negativi?
La serie comincia con Smith in ospedale, in convalescenza dopo sei mesi dagli eventi narrati nel film. Nessuno lo ha cercato, è una faccenda da supereroi, dovrei essere in carcere, dice all’uomo delle pulizie. Questi gli chiede che supereroe sarebbe e, una volta sentito il suo nome, afferma di non conoscerlo affatto. Peacemaker raccatta la sua divisa sgualcita e bruciacchiata e sgattaiola via dall’ospedale…in taxi. Arrivato a casa di suo padre, non ha i soldi per pagare la corsa, in tasca ha solo banconote di qualche sconosciuto paese asiatico. Il taxista gli chiede di avere il suo elmetto e lui glielo dà. E queste sono solo le prime scene del primo episodio. Come non amarlo già?
Ma non è solo l’aspetto comico o cringe a rendere irresistibile la narrazione. In mezzo a tanti eventi ridicoli e un po’ assurdi (un esempio per tutti, Peacemaker che, dopo essere stato assoldato per l’ennesima missione segretissima, si presenta alla prima riunione del gruppo, nel drugstore della cittadina dove tutti lo conoscono, con la divisa da supereroe, elmetto nuovo di pacca, a bordo di un’auto color…bandiera USA e accompagnato da un’aquila, la sua mascotte e miglior amica e gli altri che lo vedono arrivare non possono che dargli del coglione), c’è anche spazio per uno sviluppo del personaggio, indagando la sua personalità e il suo background culturale. Appena viene introdotto il personaggio del padre, metà del lavoro è fatto.
Pur con notevoli differenze, che ora spiegherò, questa serie ha molti tratti in comune con un altro lavoro di Gunn, il film Super – Attento crimine!!!. Film del 2010 con protagonisti Rainn Wilson (il Dwight di The Office Us), Elliot Page (allora ancora Ellen), Liv Tyler e Kevin Bacon (cattivo molto convincente). Frank Darbo è un uomo normale, che, dopo una serie di eventi sfavorevoli, si autoconvince di aver ricevuto una chiamata divina per diventare un supereroe, paladino della lotta contro il crimine. Come Smith, anche Darbo ha una visione un po’ troppo rigida e quadrata della realtà (rompe la testa con un una chiave inglese a un tizio che salta la fila, perché “le file si rispettano!”, per dire) ed è convinto di agire in nome di un bene superiore, anche se inanella una serie di errori di cui non sembra in grado di rendersi conto. La sostanziale differenza tra i due personaggi è che Saetta Purpurea, il nome da supereroe di Darbo, è un completo sprovveduto, non sa combattere e usa le armi un po’ come viene, mentre Peacemaker è un assoluto esperto in ogni forma di combattimento, con armi o senza, tanto che lo stesso Cena lo definì “una sorta di Capitan America, ma più stronzo.” Entrambi sono abbastanza infantili, entrambi dovranno in qualche modo crescere.
Una simpatica analogia riguarda i titoli di testa del film in questione e della serie. In entrambi i casi tutti i personaggi si trovano impegnati in un balletto, in Peacemaker sono gli attori stessi, in Super – Attento crimine!!! è la loro versione a cartoni animati. Nella posizione finale (finto fermo immagine) i ballerini ansimano per la fatica.
Allora, ironia, humour nero, violenza, cinismo e sfiducia nel governo centrale. Siamo quindi dalle parti di The Boys (serie Amazon, per chi non la conoscesse, tratta da un fumetto che parodia in modo spietato i luoghi comuni sui supereroi)? Sì e no, in realtà. Perché, anche se il linguaggio è abbastanza sboccato e non mancano situazioni violente e piccanti, siamo comunque nell’universo DC e quando vengono nominati eroi di grande calibro, come Superman o Batman, si percepisce un alone di rispetto e una sensazione “protezione” che proviene da quei nomi… quasi sempre, infatti lo stesso Peacemaker alimenta voci infondate sulle cose strane che Aquaman farebbe con i pesci.
Il cast: Peacemaker è John Cena, ex wrestler come The Rock e Bautista, ma che, dopo qualche tentativo nell’action movie poco riuscito, ha virato verso il comico (come in Un disastro di ragazza), trovando la sua particolare via per il successo. Suo padre è interpretato da Robert Patrick (Terminator 2, X Files), e nella squadra troviamo Danielle Brooks (Orange is the new Black), Freddie Stroma, Jennifer Holland e Chukwudi Iwuji.
La serie è interamente scritta da Gunn, che dirige anche cinque degli otto episodi. Su Tim Vision, per ora, mentre il film The Suicide Squad – Missione suicida è su diverse piattaforme, compreso gratuitamente nell’abbonamento Sky Now.