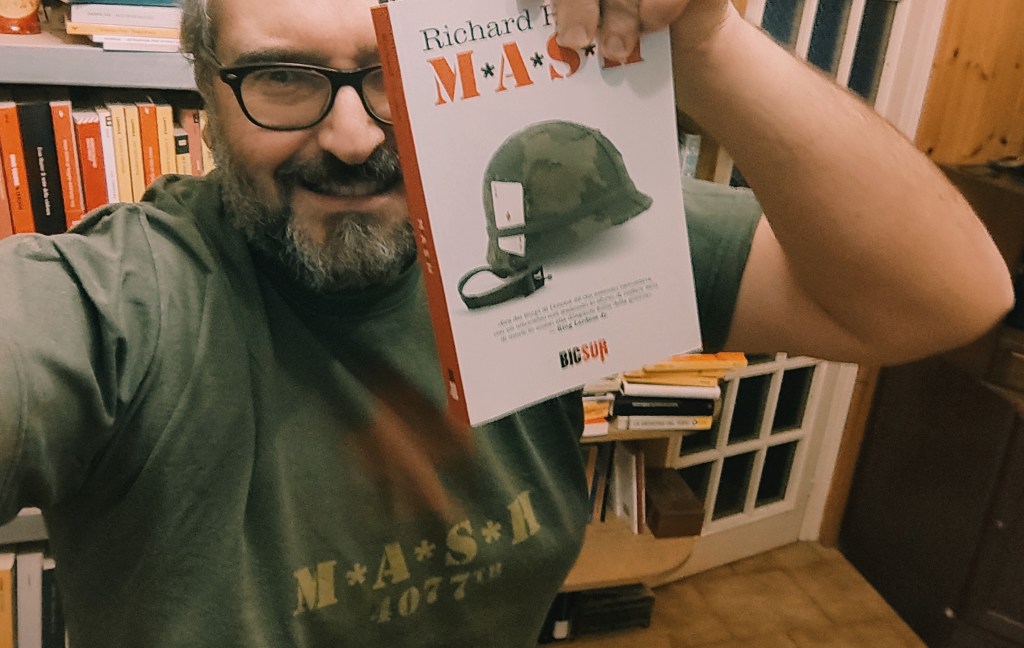Il film di James Gunn su Superman è un validissimo cinecomic, che segna una svolta, un nuovo inizio nell’universo DC.
Di solito mi astengo dalle recensioni di libri, film, serie o fumetti che tutti hanno visto, letto e recensito in mille modi diversi e di cui si sente parlare ovunque. I social strabordano, le opinioni si rincorrono, ognuno deve dire la sua, ognuno deve sentirsi chiamato in causa, come se non ne potesse fare a meno, come se la sua recensione fosse quella fondamentale, quella di cui non si poteva fare proprio a meno. Beh, io non credo di essere così importante o di avere molte cose originalissime da dire, ma sì, stavolta mi sento proprio chiamato in causa, perché sono fan di Superman fin da quando ero bambino, ho qualche idea su che cosa dovrebbe rappresentare il personaggio e, sostanzialmente, mi sento davvero soddisfatto da questa sua più recente versione e più che recensire, vorrei quasi solo ringraziare James Gunn per il suo film. La chiudo qui? No, ovviamente.

Qualche premessa. Non sono un fan polarizzato. Il fatto che mi sia piaciuto il film di Gunn non vuol dire che detesti Snyder (mi sembra anche idiota doverlo sottolineare, ma di questi tempi non si sa mai). Alcuni film di Snyder li considero proprio ben fatti, titoli come “Watchmen” e “300” sono tra le mie trasposizioni da fumetti preferite. Altre cose mi sono piaciute meno (“Rebel Moon” mi ha annoiato a morte, per esempio; ho mollato a circa metà del primo film). E in mezzo c’è lo Snyderverse, l’avventura di Zack con i principali eroi Dc. Che devo dire? Avrei sperato in qualcosa di meglio da “Man of Steel” (che comunque mi è sembrato più convincente del precedente “Superman Returns”) e anche da “Batman v Superman” (c’era sempre qualcosa incastrato a forza nelle trame oltre a… “Martha”, per esempio e l’estrema cupezza – alla ricerca di un realismo sulla scia del Batman di Nolan – non mi ha mai convinto del tutto, perché secondo me un estremo realismo non è che giovi alla lunga sui cinecomic, fatta eccezione appunto per “Watchmen”, ma quella era una storia ben precisa che, anche se con qualche modifica tra il fumetto e il film, esigeva quel tipo di atmosfera). Però la versione di Snyder della “Justice League” mi era piaciuta, anche nella cut lunga quattro ore! Poi, avendo letto come si sarebbe dovuta sviluppare la trama, ho storto un po’ il naso, perché non ero molto contento di come il personaggio di Superman sarebbe stato utilizzato, cioè, prima me lo ammazzi (e il rimando alla morte di Superman fumettistica poteva anche starci) e poi mi crei una saga in cui impazzisce e diventa una sorta di dittatore malvagio del mondo (da Injustice), cioè non è un po’ troppo per un universo “canonico”?


No, perché qui non si sta parlando di un personaggio qualsiasi, di un supereroe qualsiasi, ma del primo, dell’archetipo della stirpe. Dalla sua nascita editoriale ufficiale nel 1938 ha vissuto una serie di evoluzioni e di differenti declinazioni, per cui oggi è anche un po’ difficile dire, se non impossibile, quale possa essere la sua versione “canonica ufficiale”. Nato come superuomo forzuto che i cattivi li prendeva a sberle e morta lì, senza tante remore, è in seguito diventato il boy scout d’America, l’interprete e difensore della american way of life, un patriota buono al limite dell’ingenuità. Lo hanno fatto morire e poi risorgere, gli hanno cambiato taglio di capelli e costume, aumentando o ridimensionando i suoi poteri.


E poi, come molti altri eroi a fumetti, e forse più di altri, è stato protagonista di un sacco di storie “what if”, del tipo, che cosa sarebbe successo, se…? E se il razzo da Krypton fosse arrivato nel Medioevo? E se fosse atterrato a Gotham e lo avessero trovato i coniugi Wayne? E se invece fosse caduto nella vecchia Unione Sovietica?

E se fosse destinato a morire a causa di una eccessiva esposizione ai raggi solari, come occuperebbe gli ultimi giorni della sua via? E se un giorno il Joker uccidesse Lois e di conseguenza Superman impazzisse (qui è dove voleva andare a parare Snyder)? Ne “Il ritorno del Cavaliere Oscuro”, Frank Miller, che penso non abbia mai amato molto Superman, in un mondo dove tutti i supereroi e vigilantes sono banditi, lo dipinge come braccio armato, praticamente invisibile, del governo americano (tra l’altro di un’amministrazione Reagan non proprio simpaticissima) e nei seguiti a tale saga non è che lo tratti molto meglio (Gunn ha un approccio totalmente opposto). Anche il grande Alan Moore ha dato la sua interpretazione personale dell’eroe con la grande S rossa sul petto, in una struggente storia disegnata da Curt Swan (disegnatore dell’era classica di Superman), intitolata “Che cosa è successo all’uomo del domani?”, storia che pone fine alla Silver Age e si colloca appena prima della “Crisi delle Terre Infinite”.

Altro punto fermo della storia editoriale di Superman è la riscrittura delle origini da parte di John Byrne con la mini saga “The Man of Steel” del 1986. E allora qual è la migliore interpretazione possibile che si può dare di questo eroe che in più di 90 di vita editoriale è stato spremuto e reinventato in ogni modo? Io un’idea ce l’ho, ce l’ho da circa trent’anni e guarda caso è molto simile a quella di Gunn.
Negli anni 90, mentre il nostro eroe stava per affrontare Doomsday, il suo giorno del giudizio, nel fumetto americano c’era parecchio fermento. Stava nascendo l’Image, una casa editrice alternativa ai due più grandi colossi e a fondarla erano proprio nomi grossi fuoriusciti da Dc e Marvel, che da un lato volevano essere più indipendenti nella gestione dei propri progetti e dall’altro, banalmente, volevano guadagnare un po’ di più. Ci fu un proliferare di nuovi personaggi e nuovi team di super tizi, che si lanciavano in missioni impossibili o semplicemente cercavano di sopravvivere tra l’attacco di un super cattivo e l’altro. Il mercato si riempì di personaggi super cazzuti, spavaldi, cinici, violenti, spesso anche originali nella loro tragicità, cito per tutti SPAWN di Todd McFarlane, ma nella maggioranza dei casi erano tipacci che ci tenevano a mostrarsi duri e puri e con le “palle quadre”. Allora io mi chiesi, ma non è che in tutta sta massa di maranza dal cazzotto e dalla smitragliata facile il vero alternativo torna ad essere un tizio venuto dallo spazio, ma cresciuto in una fattoria del Kansas, che crede, anche in modo abbastanza ingenuo e naif, nel… scusate la parolaccia… bene? Deve esserselo chiesto anche Gunn ed è su questo principio e su ciò che ne consegue, prendendo spunti qua e là, da una serie di fumetti in cui questo aspetto è più evidente, che ha rifondato e rimodellato il personaggio. Lo dico una volta e non ci torno su, il woke non c’entra niente.

Quindi Gunn dove va a pescare l’ispirazione? Lo spirito potrebbe essere in senso lato simile a quello dei film con Christopher Reeve, ma ovviamente qualcosa andava aggiornato e l’aggiornamento riguarda l’umanità del personaggio. Superman non è un dio, non ha l’incondizionato plauso di tutta la gente, l’ammirazione e lo stupore. Basta qualche fake news battuta da una scimmia sui social e viene messo in discussione. Superman diventa umano, sbaglia e cerca di rimediare ai propri errori e così cresce. Tornando ai fumetti, vorrei citare solo due storie in cui i riferimenti sono abbastanza espliciti: “All Star Superman” di Grant Morrison e Frank Quitely (molto dell’ambientazione e anche il tanto criticato costume vengono da lì) e “Superman: Stagioni” di Jeph Loeb e Tim Sale.

Nel film Superman è già in azione da tre anni, le sue origini non sono ribadite (per fortuna, si ripensi al minutaggio dedicato a Jor-El/Russel Crowe in “Man of Steel” del 2013, tutto tempo guadagnato, che Gunn sfrutta in altro modo, rendendo il film meno lungo e più denso di avvenimenti “pregnanti”) e la storia si apre in medias res, con la sua prima sconfitta. Superman viene battuto dal campione di un Paese, la Boravia (nazione fittizia, alleata con gli USA), che sta invadendo uno Stato vicino ed ha reagito all’intromissione di Superman nelle sorti della guerra. Superman che viene pestato? Sì, ma ci sarà una motivazione chiara e plausibile a tutto. Anche se si tratta di un film tratto dai fumetti, che non fa nulla per sembrare realistico nello stile cupo che aveva finora caratterizzato le produzioni DC, non vuol dire che non abbia la sua coerenza. Sospendiamo l’incredulità, ma non la capacità di concatenare gli avvenimenti in modo che abbiano senso e consequenzialità. Gunn è molto preciso nella scrittura, riesce a gestire molti personaggi e dar loro un peso e una funzione, anche se hanno poche battute. Storia da fumetti, ma che si regge in piedi benissimo. Superman ha una sua visione del mondo e dell’umanità, forse un po’ ingenua e utopistica, ma è quella che incarna in modo più preciso lo spirito del personaggio. Si mette al servizio di tutti (salva bambini, donne e uomini, un cane, uno scoiattolo e cerca pure di salvare un mostro gigante che imperversa su Metropolis), al servizio del bene (repetita iuvant), ma lo fa rappresentando sé stesso, senza nessuna bandiera nazionale sulla testa (e forse questo ha dato un po’ fastidio), oltretutto, avendo palesemente dichiarato la sua provenienza aliena, è più che mai un immigrato, malvisto da chi ne mette in dubbio la sincerità delle sue azioni disinteressate (uno su tutti Luthor). Non mi dilungherò raccontando la trama che, pur non essendo poi così complicata, dà modo e spazio di far succedere un sacco di cose, ma vorrei concludere mettendo in evidenza quello che funziona molto bene (quasi tutto) e ciò che invece mi ha lasciato qualche dubbio (in realtà molto poco). Dicevo che i personaggi sono descritti in modo preciso, Superman e Lois hanno una chimica coinvolgente. David Corenswet a me non ha fatto rimpiangere Henry Cavill (che comunque sembrava nato per interpretare l’uomo d’acciaio), è una versione più pop dello stesso personaggio, che mostra maggiormente le sue debolezze e i suoi dubbi, ma che è pur sempre Superman, per cui non si arrende mai. Rachel Brosnahan (che fu la protagonista della serie “La fantastica signora Maisel”) incarna una delle miglior Lois di sempre, (la migliore, dai, diciamolo), che dimostra carattere, intelligenza e coraggio, senza essere il solito stereotipo della donna “forte”, con le p…. (no, non lo posso scrivere). Tra i due all’inizio c’è un dialogo che dimostra quanto Gunn sia bravo nella scrittura e costruzione dei personaggi e nella loro interazione.

Il Lex Luthor di Nicolas Hoult è l’incarnazione di un ambizioso tecnocrate (ricorda qualcuno?), che vede minacciata la sua sete di potere dalla sola esistenza di Superman e, mentre per tutto il film si mostra cinico e freddo, si rivelerà in fondo per quel livoroso che è. Ma Gunn, oltre a saper scrivere, è anche un regista coi fiocchi. Ci sono scene di volo, di battaglia, piani sequenza che raramente si vedono in un cinecomic, scene in cui quello che conta osservare è sullo sfondo (almeno in due occasioni diverse e con finalità differenti, ma comunque originali e azzeccatissime). Tutto esposto in modo chiaro ed emozionante e senza trucchetti. Eh, sì cari criticoni degli effetti speciali, le scene sono quasi tutte di giorno, alla luce del sole, con colori sgargianti e la grafica ne esce proprio bene, non come in alcuni film in cui per nascondere le magagne si fa tutto di notte, magari con la pioggia. E poi c’è Krypto, forse un po’ invadente nell’economia dell’intera vicenda, ma anch’esso funzionale, ha senso che sia lì e che faccia ciò che fa.

Come si è capito ed è già stato ribadito da molti, questo è anche un film politico. Se inserisci in un’ambientazione verosimile al mondo attuale un personaggio, a suo modo “ingombrante” come Superman, un certo impatto sulla comunità internazionale ci sarà per forza. Che cosa farà? Come agirà? Per chi parteggerà? Ma è bene ricordare che qui si va ben oltre i “grandi poteri che portano grandi responsabilità”. Non è scontato che Superman agisca come fa. Potrebbe stare fuori dai giochi e vivere tranquillo, chi glielo impedirebbe? Potrebbe intervenire per mero interesse personale, per noia o per capriccio (come il pazzo Homelander di “The Boys”), oppure potrebbe anche decidere di dominare il mondo; chi sarebbe in grado di fermarlo?
E invece no. Superman SCEGLIE di operare per la giustizia (che, come si sa, spesso cozza contro leggi e le convenzioni internazionali). In ogni caso Gunn la sceneggiatura l’ha finita nel 2023, prima che (ri)esplodessero i focolai in Medio Oriente (ma è poi così poco prevedibile un canovaccio simile?). Che cosa non mi è piaciuto allora? Krypto è simpaticissimo, creato in modo egregio con la CGI, punk, ingestibile, forse lo avrei utilizzato un po’ meno (Gunn si è ispirato al proprio cane, recuperato in un canile e pare che dall’uscita del film siano aumentate in modo esagerato le richieste di adozioni di cani abbandonati, qualcosa come +500%). Un’altra cosa che mi ha lasciato un po’ così è l’eccessivo numero di personaggi. Non è un film corale, è sempre un film su Superman, che è sempre e comunque centrale. Potrebbe darsi che Gunn abbia in mente film o serie in cui questi personaggi abbiano un loro sviluppo. Credo che il primo potrebbe essere Mister Terrific, che nel film non è proprio marginale e ricopre un ruolo abbastanza decisivo. Poi forse anche la redazione del Daily Planet avrà sviluppi, oltre a Lois è Jimmy Olsen ad agire in modo concreto, ma altri componenti dello staff hanno poca ragione d’essere, se non come mero riempitivo.

Viene ripreso il personaggio della signorina Teschmacher, che nei fumetti non c’è, ma è stata creata nei film con Reeve, un omaggio al regista Richard Donner, assistente di Luthor che continua a farsi selfie, bella e svampita, ma forse un po’ meno di quanto si crede. Ecco se devo dire l’unica cosa che non mi è piaciuta, nel senso che ci stava, ma io l’avrei messa altrove è la dichiarazione che fa Superman verso la fine del film, parlando di sé e dicendo che fa un mucchio di cazzate, ma che ci prova, in sostanza. Ecco, lo dice a Luthor, un Luthor furioso e sconfitto, non glielo dice però con tono beffardo, ma quasi come se fosse un “non prendertela su, va così per tutti”. E Lex per tutto il film aveva cercato di eliminarlo, uccidendo anche parecchie persone (in un caso macchiandosi di una vera e propria esecuzione, davanti ai suoi occhi). Secondo me questa frase Superman la può e la deve dire, ma magari a Lois, a qualcuno della Justice League, parlando tra sé e sé coi suoi robot senzienti. Dirla a Luthor, boh, mi è sembrata una forzatura.
Qualche piccola chicca. Nella parte di un giornalista televisivo c’è il figlio di Christopher Reeve. Frank Grillo interpreta il ministro della difesa, Rick Flag senior (padre di Rick Flag, apparso in “Suicide Squad”, sempre di Gunn) e comparso nella serie animata “Creature Commandos”, la vera prima uscita del nuovo universo DC, recuperabile in chiaro sul canale Youtube ufficiale di MAX.

Tra gli intervistati in tv compare, in un piccolo e divertente cameo, il Peacemaker di John Cena, uno dei pochi personaggi rimasti dal precedente universo cinematografico DC; a breve uscirà la seconda stagione dedicata a questo controverso personaggio, di cui ho già parlato qui (assieme al cinema di Gunn pre azzurrone):
Che altro dire? A me il film è piaciuto, perché intrattiene, racconta, emoziona, non si prende troppo sul serio, ma è comunque solido nella scrittura e nella realizzazione e messa in scena. Mi sembra un buonissimo inizio per la nuova avventura di James Gunn con l’universo dei cinecomic DC.
E mi ha fatto un po’ tornare bambino.