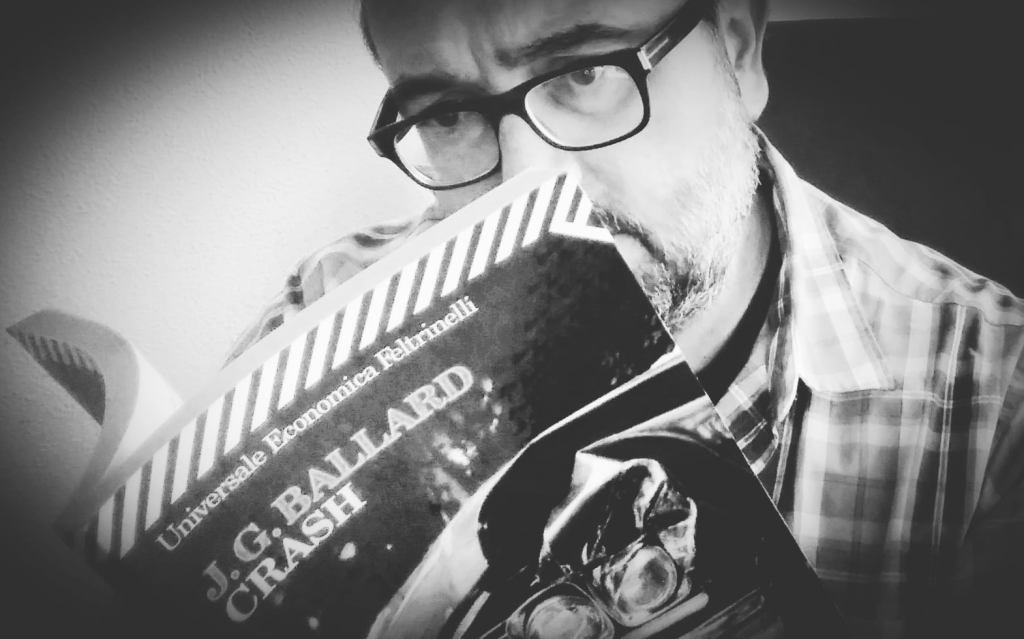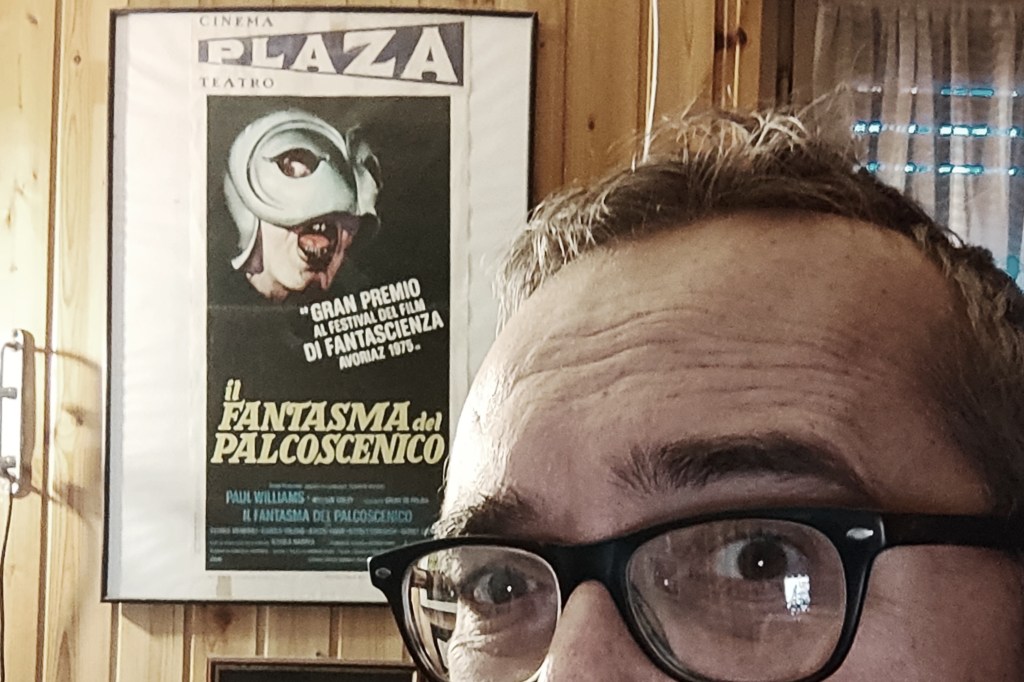Premessa. Tarantino non si discute, o si ama o si odia, c’è poco da dire. Personalmente l’ho subito amato alla follia da quando ho visto “Pulp Fiction”, in una piccola sala di Milano. All’epoca ero poco più che ventenne e mi trovavo in un periodo della mia vita denso di studi, speranze e sogni, università, scuola del fumetto, aspirazioni letterarie. Oggi attendo con discreta ansia da fan l’uscita del suo prossimo film, di che parlerà? Sarà davvero l’ultima sua opera cinematografica?
Intanto quest’estate, sotto l’ombrellone, ho avuto modo di leggere la versione romanzo di “C’era una volta a Hollywood” e ne sono stato piacevolmente stupito. Non si tratta della semplice trasposizione su carta del film e nemmeno del rimaneggiamento della sceneggiatura, tanto è vero che alcune situazioni sono presentate in modo differente (smorzo un eventuale entusiasmo, il finale è molto diverso, anche se la storia del lanciafiamme è comunque citata). Tarantino crea un universo in cui mescola personaggi, serie televisive, film e situazioni vere con altrettanto materiale inventato di sana pianta, il tutto amalgamato in maniera davvero coinvolgente. Non sono qui a scoprire l’acqua calda se dico che Tarantino è un vero affabulatore, ma non mi aspettavo che lo fosse a un livello tale anche dal punto di vista letterario. Certo, molti riferimenti non sono del tutto comprensibili, parte di quanto raccontato riguarda la cultura cinetelevisiva strettamente statunitense (e alcune cose citate credo che da noi non siano mai neanche state trasmesse), però finché si parla di serie come “Mannix”, “Ricercato vivo o morto” (la serie che lanciò Steve McQueen) o “Due onesti fuorilegge” ci si può arrivare ed è interessante immaginare un lungo filo rosso che unisce insieme tante diverse produzioni, un filo che si avvolge a gomitolo in un percorso intricato, ma godibile.
La storia è sostanzialmente la stessa del film, ci sono Rick Dalton, l’attore in crisi e il suo stuntman amico e factotum Cliff Booth, c’è Sharon Tate con i suoi sogni e la Manson Family, attori e registi al top come Roman Polanski e Steve McQueen e stelle cadenti come Aldo Ray che, dopo aver lavorato con celebrità del calibro di Bogart e Katharine Hepburn, finirà in filmacci come quelli diretti da Al Adamson (nome che è l’emblema di un brutto cinema, ma che Tarantino, nella sua voracità, sembra conoscere bene, citandolo più volte). La scrittura dà la possibilità all’autore non solo di raccontare più cose con maggiori dettagli, ma anche di spiegare meglio i caratteri e le motivazioni dei propri personaggi. Quando il Tarantino “narratore onnisciente” si immerge nei personaggi è una vera e propria goduria e le pagine volano via senza accorgersene. Così scopriamo un po’ del passato di Booth, eroe di guerra, del perché ha quel cane (un racconto degno del migliore Joe R. Lansdale o di quel Elmore Leonard, dal cui “Punch al rum” Tarantino trasse il suo “Jackie Brown”), veniamo a sapere i retroscena dei suoi omicidi, quello della moglie compreso, e di come l’ha fatta sempre franca. Perfino l’incontro / scontro con Bruce Lee è molto più chiaro e anche le motivazioni del campione di arti marziali vengono attentamente indagate. Allo stesso modo tutti i dubbi e le insicurezze di Dalton sono meglio esplicitate, il suo sentirsi ai margini di un sistema che sembra ormai offrirgli poche possibilità di riscatto e allo stesso tempo la sua caparbietà, l’ostinazione profonda a voler dimostrare di essere ancora qualcuno.
Attraverso gli occhi dei personaggi possiamo inoltre vedere non solo la conoscenza profonda che l’autore ha del cinema (made in Usa, internazionale e italiano), ma anche diverse concezioni e punti di vista. L’idea di cinema di Booth, che riempie le ore vuote del suo tempo tra una sala cinematografica e l’altra, sconta un inevitabile paragone con quello che è stato il suo passato, in guerra. Cliff apprezza i film in cui il narrato si avvicina il più possibile al vero. Al contrario Dalton vive ricordando i set che ha frequentato, con chi ha lavorato e se il “prodotto finale” fosse poi degno di nota. Valuta la forza del film, il suo successo. È divertente quando un regista paragona il personaggio che Rick deve interpretare ad Amleto e fa continui riferimenti shakespeariani, mentre siamo sul set di un telefilm western, e Dalton ammicca, ma dentro di sé è consapevole di non avere i riferimenti culturali adeguati. Lo stesso Manson è visto non solo come manipolatore e corruttore di giovani, ma anche come aspirante cantautore mancato. E la scena, raccontata anche nel film, in cui si reca nella casa vicino a quella di Dalton, mentre Cliff è sul tetto ad aggiustare l’antenna, assume un significato più profondo.
Poi ci sono un sacco di altre cose. L’aneddoto di Dalton che avrebbe potuto avere la parte di Steve McQueen ne “La grande fuga”, i baffoni da hippy appioppati al personaggio di Caleb, sul set di “Lancer” (serie vera), tanto agognati da James Stacy (attore realmente esistito) e il rapporto tra Rick (come sappiamo personaggio inventato), sullo stesso set, e la piccola attrice Trudi Fraser (altro personaggio inventato, che già da bambina aspira a vincere l’oscar, ma il futuro le riserverà solo una nomination come miglior attrice protagonista in un film… di Quentin Tarantino, che non esiste!). Altre chicche: un elogio a una inquadratura particolare di Polanski in “Rosemary’s baby” e la spiegazione del ruolo non accreditato ufficialmente del “ringer”.
Il romanzo si chiude con una nota di speranza, almeno per Rick, che sembra aver fatto pace con sé stesso, dopo una conversazione (che nel film non c’è) niente popò di meno che con Steve McQueen e una telefonata con Trudi (scena girata, ma tagliata dalla versione finale della pellicola) che gli fa capire che, in fin dei conti, lavorare come attore non è sta grande tragedia, anzi, è una fortuna che pochi possono permettersi.
Che cosa manca? Beh, rispetto al film, l’aggressione che finisce con il lanciafiamme è solo accennata e, quando Cliff si reca al ranch occupato dalla Manson family, non c’è la spassosa scena in cui, dopo aver trovato una gomma bucata alla sua auto (in realtà è la Cadillac Coupe de Ville del 1966 color giallo crema di Dalton), costringe il tizio che ha commesso quel gesto a cambiare la ruota.
Un’allegra cavalcata in discesa di quasi 400 pagine e ne avrei lette altrettante, alla fine. Io non so se davvero Tarantino terminerà la sua carriera da regista dopo il decimo film (di cui ancora non si sa nulla); spero proprio di no, ma mi auguro che almeno continui a scrivere, perché, per dirlo in modo pulp, lo fa fottutamente bene.