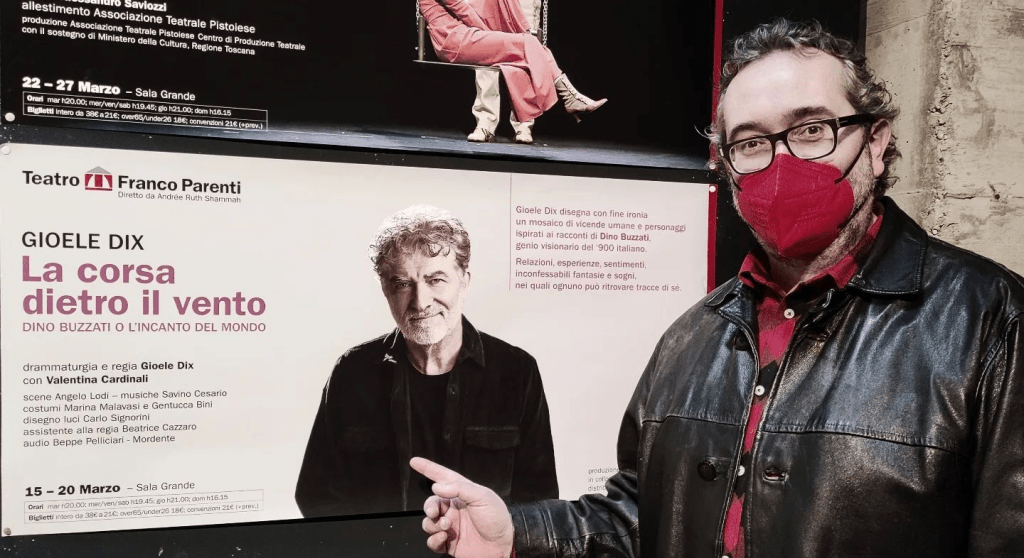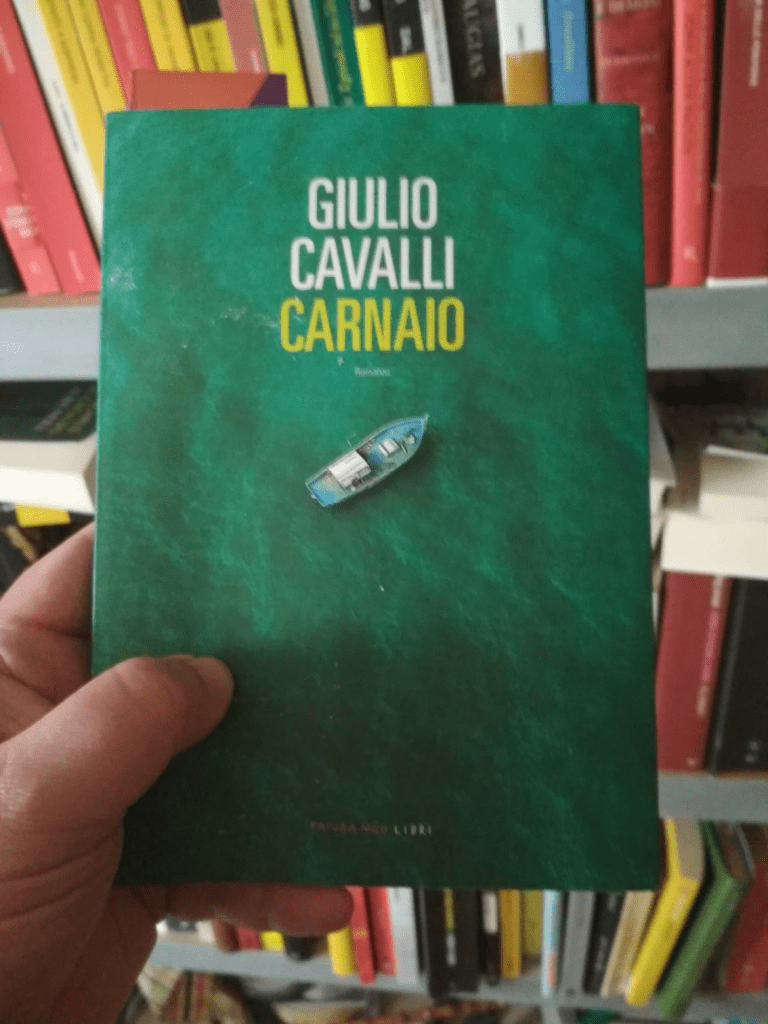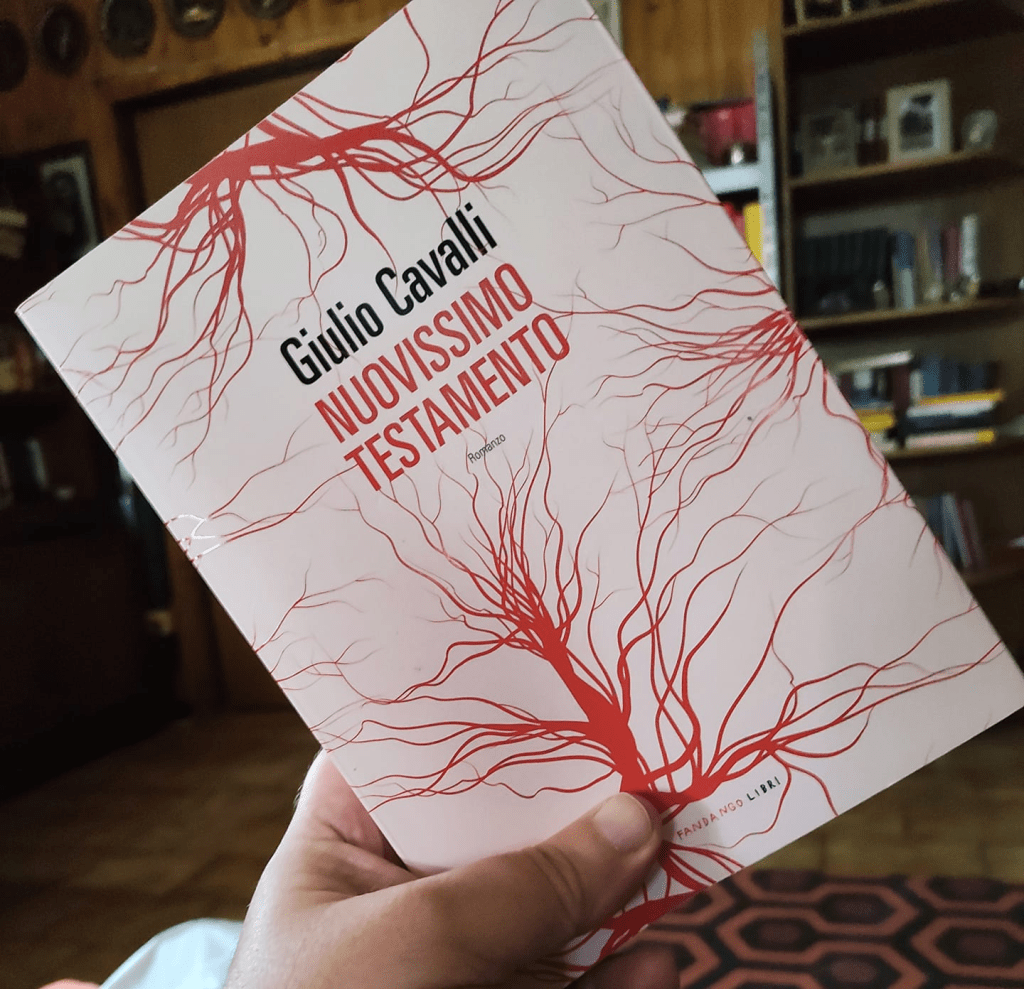Vincitore del premio Oscar nel 2021 per la migliore sceneggiatura originale, “Una donna promettente”, da poco visibile (gratis) su alcune piattaforme di streaming, è un film da vedere e far vedere e dal quale prendere spunto per intavolare anche dibattiti di un certo peso.
Partiamo da una frase infelice che non c’entra nulla con il film in questione, (o forse no). “L’amore fa fare cose pazze” ha detto Will Smith mentre ritirava pochi giorni fa la statuetta per il miglior attore, durante la serata degli Oscar. Poco prima lo stesso Smith aveva colpito il presentatore Chris Rock, a seguito di una battuta veramente pessima nei confronti di sua moglie. Davvero è l’amore che fa fare cose pazze? E quali sarebbero queste cose pazze? La violenza può essere annoverata tra queste cose pazze?
Sia chiaro che non è mia intenzione accomunare Will Smith, che tra l’altro come attore mi piace e mi sembra anche un tipo simpatico, a uomini violenti e, anzi, la sua azione è stata mossa da un eccesso di difesa nei confronti della moglie (ma chiediamoci, le donne hanno bisogno di una tale difesa?), ma quella frase, detta a conclusione dei ringraziamenti (e di parte delle scuse) mi ha fatto pensare. Troppe volte un concetto del genere è stato usato nei tg e sui giornali per trovare un senso, se non proprio una giustificazione, ad azioni di persone che per troppa gelosia o per troppo amore hanno finito per ferire o uccidere chi dicevano di amare. Ma sto rischiando di divagare troppo.
Il film di cui parlo in questo post non tratta certo di amore (se non per sottrazione o di amore genitoriale, se vogliamo), ma piuttosto di un gigantesco elefante nella stanza, che molti sembrano non vedere, e che in parte riguarda anche il gesto impulsivo di Will Smith (almeno in senso lato). Il machismo tossico. Dilagante come un virus che si diffonde nell’aria e pronto ad attecchire ogni volta che si trova una giustificazione a un atto che non deriva certo dall’amore, è un male oscuro che noi maschietti facciamo fatica a scrollarci di dosso.
Scritto e diretto da Emerald Fenner, già sceneggiatrice di “Killing Eve” (serie britannica spy e thriller, tutta al femminile, con Sandra Oh e Jodie Comer, visibile su Tim Vision), Una donna promettente (Promising Young Woman) narra la storia di una donna trentenne che, lasciati gli studi di medicina, per un motivo che non rivelo (è il core della vicenda), lavora in una caffetteria e di notte si dedica a un rischioso passatempo. Questo lo spiego, perché già si capisce bene nel trailer qui sotto. Frequenta locali, da sola, si finge ubriaca nell’attesa che qualche “bravo ragazzo” le si affianchi per aiutarla. Già dalla prima scena vediamo tutto questo, capiamo che la donna in questione deve avere come minimo un disturbo o un trauma nel suo passato, ma è come poi procede la storia che è avvincente e allo stesso tempo sconsolante.
Avvincente, perché il film è scritto, recitato e diretto benissimo e fino all’ultima scena ha qualcosa da dire. Sconsolante, perché ci troviamo di fronte a una rappresentazione iperbolica, ma neanche poi troppo, di quella che è la realtà di tutti i giorni. Quante donne subiscono violenze e abusi tutti i giorni, senza poter difendersi o denunciare? Quanti uomini trovano giustificazioni alle molestie o a veri e propri stupri e riescono a farla franca? Eravamo giovani, eravamo ubriachi, lo voleva anche lei… in fondo se l’è cercata.
Il sottogenere cinematografico detto “rape e revenge” ha vissuto negli anni 70 una vera epoca d’oro, se così la vogliamo chiamare. A metà strada tra denuncia (ma temo non fosse il vero motivo di tanta fiorente produzione) e il voyeurismo dell’exploitation (sfociato nella sexploitation) venivano messe in scena vicende truci che avevano come filo conduttore un atto di violenza iniziale e una vendetta finale altrettanto spietata (se non di più) e, a suo modo, catartica.
Film come “Non violentate Jennifer” (I spit on your grave), “La casa sperduta nel parco” o anche “L’ultimo treno della notte” (di Aldo Lado, con Enrico Maria Salerno) non si perdevano certo in discussioni filosofiche o sociali (a parte forse l’ultimo dei tre, ma in brevissima parte), ma si limitavano a tratteggiare un mondo violento e senza pietà, dove la vendetta, anche se non poteva certo riparare al male subito, andava a sostituirsi alla giustizia, in modo da appagare le brame più nascoste di un pubblico affamato di “immagini proibite”.
Non so se Emerald Fenner conosca questo filone cinematografico, ma mi piace vedere Una donna promettente come versione adulta e fatta bene di quei film di genere (che spesso erano bruttini, per molti aspetti). Anche qui non ci sono disquisizioni morali, ma basta la descrizione della realtà. La violenza c’è sempre stata, ma fa più male, se è più subdola, nascosta, in un mondo che si proclama giusto e paritario, soprattutto se a perpetrarla sono uomini per bene, avviati a sicure carriere di successo. Uomini che se la caveranno sempre.
Nel cast Carey Mulligan (“Shame”, “Il grande Gatsby”), convincente nel ruolo di Cassie, la protagonista, Bo Burnham, Alison Brie e Chris Lowell (entrambi nel cast di “Glow”), Clancy Brown (“Highlander”, “Billions”, “Dexter: new blood”), Laverne Cox (“Orange is the new black”) e Alfred Molina (“Chocolat”, “Spider-man 2”).
Il film è visibile sulla piattaforma NOW Tv.