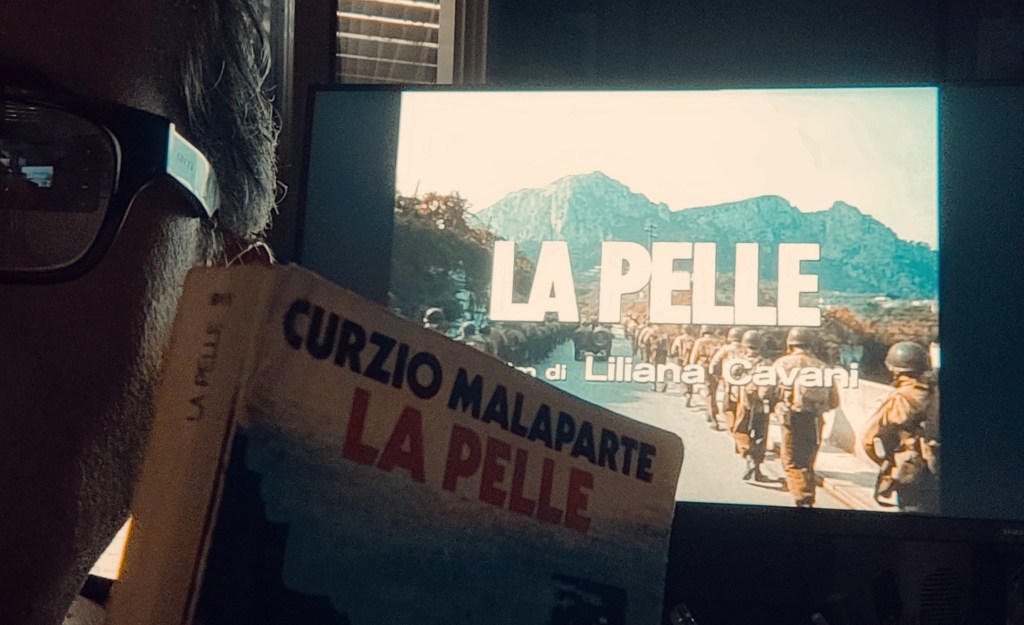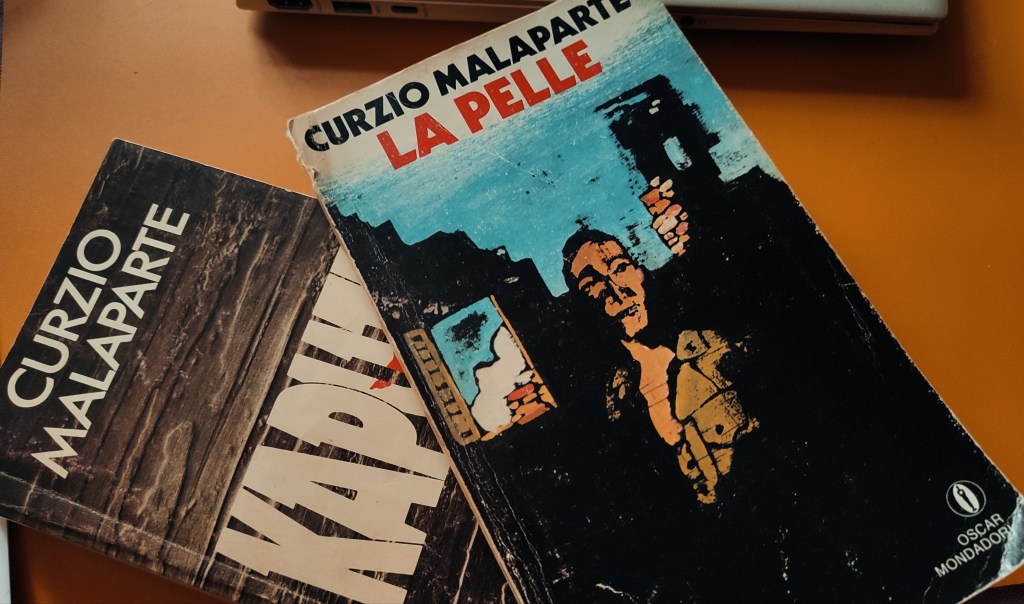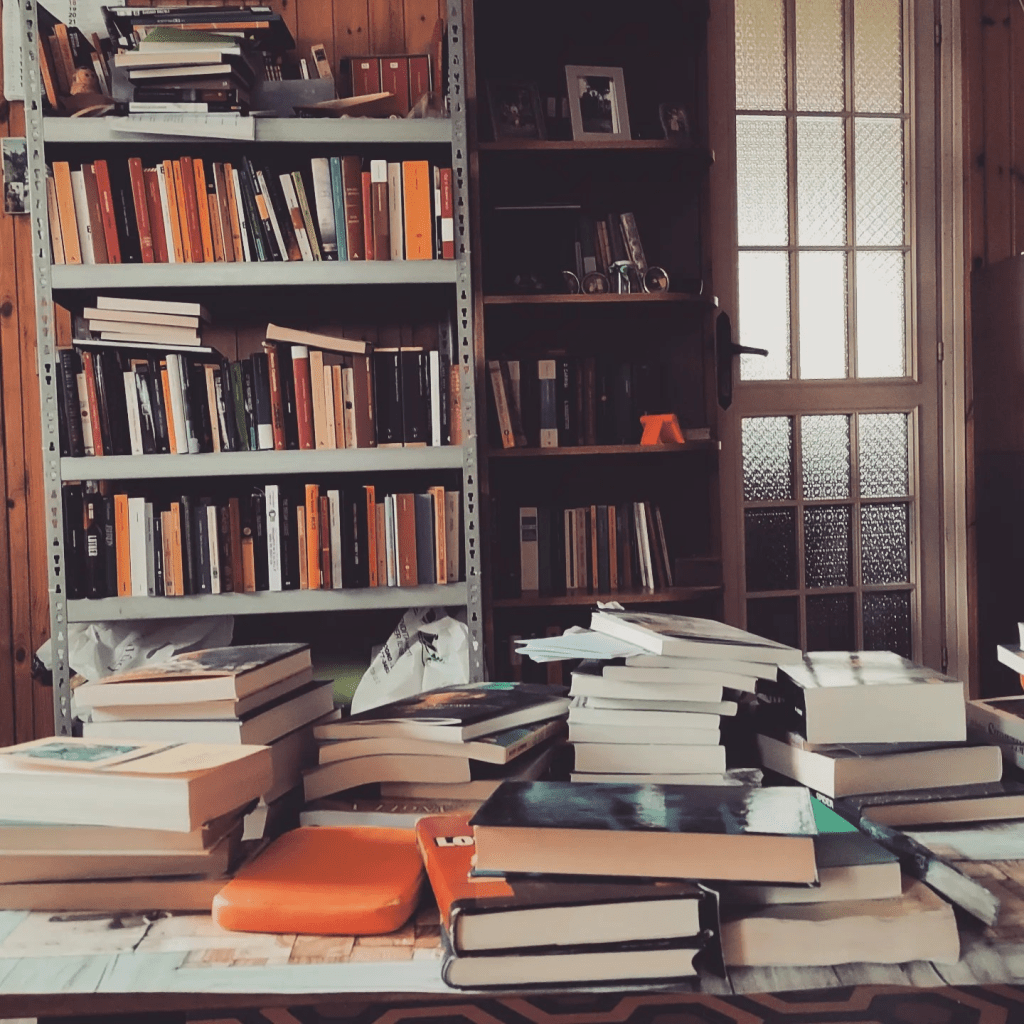Stallone contro Swarzenegger: si rinnova la sfida tra gli storici protagonisti di tanti action movie dagli anni 80 in poi, oggi ultrasettantenni ma quanto mai arzilli. Il nuovo campo di gioco? Le serie sulle piattaforme di streaming, ovviamente.
Chi non conosce Sylvester Stallone e Arnold Swarzenegger, amichevolmente chiamati Sly e Swarzy? Formazione e origini diverse, americano di origine italiana uno e campione di body building austriaco l’altro, quasi coetanei, Sly è del 1946 e Swarzy del 1947, cominciano la carriera di attore entrambi negli anni 70, prendendo parte anche a film di un certo livello, spesso in camei non accreditati. Entrambi lavorano con Altman, Sly in M.A.S.H. (di cui ho scritto qui), e Swarzy ne “Il lungo addio”, film tratto da Chandler con Philip Marlowe come protagonista (in quel caso interpretato Elliot Gould). Sly si imbatterà in Marlowe nel film “Marlowe poliziotto privato”, ma in quel film il famoso detective privato avrà il volto di Robert Michtum. Stallone lavora con Woody Allen ne “Il dittatore dello stato libero di Bananas” (scena spassosissima sul metrò), con Alan J. Pakula e Peter Bogdanovich, Swarzy con Bob Rafelson e Hal Needham.
Ma è a cavallo del decennio successivo che la sfida tra questi due colossi ipermuscolosi si accende. Sly diventa Rocky (i primi due film sono ancora negli anni 70) e poi Rambo, Swarzy incarna Conan e poi si trasforma in Terminator, franchise che non hanno bisogno di presentazioni. A Rambo, Swarzy risponde con “Commando”, film che, nonostante un buon successo, non avrà seguiti. Entrambi diventano poliziotti, agenti speciali e quant’altro, entrambi esplorano generi differenti, sempre piegati all’action, come la fantascienza. Per quello che mi ricordo, Sly non farà mai film fantasy e Swarzy non affronterà mai il sottogenere sportivo. Carriere opposte, in competizione, ma anche accomunate e piene di piccoli intrecci, che una specie di nerd come me va in crisi se non sottolinea. Almeno qualcuna. In “Jado”, tratto dal fumetto fantasy “Red Sonja” (in originale il titolo era quello, ma si preferì da noi intitolarlo col nome del personaggio maschile, evidentemente per sfruttare il ricordo di Conan), Swarzy recita al fianco di Brigitte Nielsen (Red Sonja, appunto), che in Rocky IV sarà la moglie di Ivan Drago e nella vita sposerà Stallone (da sposati compariranno insieme in “Cobra”). Nel primo Predator, al fianco di Swarzy combatte Carl Weathers, che fu Apollo Creed nella saga di Rocky. Nel fantascientifico “Atto di forza – Total Recall” (film di grande intrattenimento, ma che ha in gran parte travisato il racconto di Philip Dick da cui è tratto) Swarzy è sposato (per finta) con una bellissima Sharon Stone, (allora trentaduenne sul punto di rinunciare alla carriera cinematografica, perché la grande occasione sembrava non arrivare mai, nonostante fosse già in pista da svariati anni; due anni dopo avrebbe fatto il botto con “Basic Istinct”) con la quale ingaggia una scena di lotta (tornerà a lavorare con lei in “Last Action Hero”, uno dei suoi film più divertenti, ma all’epoca poco apprezzato, film che rielabora l’idea che già fu di Woody Allen in “La rosa purpurea del Cairo”, ossia che dei personaggi cinematografici possano uscire dal loro film e confrontarsi con la vita reale), mentre Sly avrà a che fare con Sharon Stone ne “Lo specialista”, dando vita a una scena erotica, sotto la doccia, tra le più rigide e ingessate della storia del cinema (lei a dire il vero ce la mette tutta, lui si limita a tirare i muscoli e a tener dura la mascella). Tra le varie declinazioni possibili dell’action, entrambi esplorarono il sottogenere del buddy movie, Swarzy con “Danko” (1988) in coppia con Jim Beluschi e Sly con Tango & Cash” (1989), affiancato da Kurt Russell, due film dall’alto tasso di intrattenimento.
Una volta conquistata Hollywood (e i due assieme ad altre star come Bruce Willis sostennero la catena di ristoranti “Planet Hollywood”), arriva dagli anni 90 in poi il momento di provare a rinnovarsi. Inaspettatamente è Swarzenegger quello che appare più duttile, riuscendo a interpretare qualche commedia di discreto successo, come “Gemelli” (che è del 1988), “Un poliziotto alle elementari”, “Una promessa è una promessa”, a volte mescolando l’action col genere comedy, come in “Last action hero”, già citato sopra e “True lies”, di cui parlerò anche dopo come riferimento alla serie FUBAR. Per Stallone il capitolo “commedie” rappresentò invece un buco nell’acqua. “Oscar – un fidanzato per due figlie”, remake di una commedia brillante francese, nonostante la regia di John Landis (“Animal House”, “The Blues Brothers”, “Una poltrona per due”) e un cast variegato e internazionale (c’è perfino Ornella Muti), non riesce a fare breccia nel pubblico e lascia la critica abbastanza fredda. Ma il peggio doveva ancora venire. Sì, perché la leggenda vuole che quel burlone di Swarzy, letto il copione di una commedia tremenda, fece in modo che a Sly arrivasse notizia che era proprio intenzionato a interpretarla e Sly ci cascò con tutte le scarpe, facendo di tutto per accaparrarsela. Così prese forma quello che Stallone stesso considera il suo peggior film: “Fermati, o mamma spara”. In realtà non fu un flop, la vendita dell’home video superò addirittura gli incassi del botteghino, però, anche se il plot poteva essere interessante, la resa fu davvero povera. Un poliziotto tutto d’un pezzo ospita a casa sua madre e lei gli stravolge la vita. Dire che Stallone non fosse adatto a un ruolo del genere è un eufemismo (c’è una scena onirica in cui il protagonista, stressato dalla presenza materna si immagina con in dosso un pannolino… Stallone col pannolino, forse una delle cose più tristi immaginabili). Dopo quell’esperienza Sly capì che la commedia non faceva per lui, tornò al genere action, ma nel 1997 stupì tutti partecipando a un film che forse rappresenta la sua vetta artistica, “Cop Land”, diretto da James Mangold (regista di non molti film, ma sempre molto particolari, sarà il regista del quinto capitolo della saga di Indiana Jones, a breve al cinema) e con un cast di assoluto rispetto che comprende Harvey Keitel, Ray Liotta e Robert de Niro. La prova di Stallone, che vinse il premio come miglior attore al festival di Stoccolma, è davvero notevole: smessi i muscoli (è ingrassato ad arte) e il piglio da macho dà il volto al gentile e (all’apparenza) tontolone sceriffo, con qualche problema di udito (a causa di un atto eroico compiuto in gioventù, che a me non può che ricordare il George Bailey de “La vita è meravigliosa”), che gestisce la legge in una cittadina dove abitano molti poliziotti, e dove allignano violenza e corruzione. E lui dovrebbe essere il parafulmine perché tutto passi sotto silenzio. Anche Swarzy, a dire il vero, ha avuto i suoi bei passi falsi: nel 1997, ad esempio, è stato candidato ai Razzie Awards come peggior attore non protagonista per il ruolo di Mr. Freeze nel peggior film di Batman mai concepito, quello con protagonista George Clooney, ma in quel caso era tutta la produzione ad aver fatto un pessimo lavoro e le candidature erano letteralmente fioccate (il Razzie se lo aggiudicò Alicia Silverstone, per la parte di Batgirl).
Negli anni successivi entrambe gli attori andarono sul sicuro, prendendo parte a produzioni in linea con quanto ci si poteva aspettare da loro e cercando di rivitalizzare vecchi miti. Ma se, dal terzo film in poi, la saga di Terminator è andata sempre di più nel pallone, Stallone ha fatto tornare a casa Rambo e ci ha mostrato l’anziano Rocky dispensare insegnamenti di vita (dando indirettamente il via al franchise di Creed, dal quale sarà escluso nel terzo capitolo). Alla fine, siamo riusciti a vederli assieme sullo schermo, grazie alla serie di film voluta da Stallone “I mercenari – The Expendables” (del primo film Sly è anche regista). Swarzenegger e con lui Bruce Willis fanno poco più di un cameo. Sta per uscire il quarto capitolo e non ho ancora capito se Swarzy sarà della partita.
Ma veniamo all’oggi. La sfida si rinnova a distanza con due serie su due canali di streaming differenti (in realtà sarebbero due serie a testa, ma a me interessano solo quelle di fiction). Sylvester Stallone è da parecchi mesi su Paramount + con Tulsa King e di recente Arnold Swarzenegger è sbarcato su Netflix con FUBAR (acronimo per Fucked up Beyond all Recognition). Quale sarà la migliore? Dopo averle viste entrambe posso dare qualche indicazione, cercando di evitare troppi spoiler.
TULSA KING
Dwight Manfredi (Stallone), detto il generale, è un affiliato a una delle famiglie mafiose più potenti di New York. Dopo aver scontato 25 anni di galera, per aver taciuto sulle dinamiche di un fatto criminoso, di cui si è preso la colpa, torna all’ovile, ma l’accoglienza che trova non è quella che si aspetta. A parte il vecchio boss, gli altri membri del clan si rivelano abbastanza freddi con lui. Gli viene quindi proposto e quasi imposto di spostarsi a Tulsa e creare lì un nuovo giro di affari. Tutto questo succede nei primi minuti del primo episodio, non sto svelando nulla che non fosse già palesato dal primo teaser. In realtà, da come veniva presentata proprio nel primo trailer, pensavo che la serie fosse molto più cupa e seriosa; invece, la questione della detenzione e della fedeltà è smarcata abbastanza alla svelta (verso la fine ci sarà un flashback che andrà a svelare come e perché il generale venne arrestato e, beh, l’ho trovato abbastanza pleonastico e un po’ deludente). Premetto che la serie mi è piaciuta, l’ho trovata godibile e anche abbastanza dinamica, anche se spesso bisogna dimenticarsi di avere un giudizio oggettivo, insomma c’è da accendere al massimo la sospensione dell’incredulità e godersi quello che si vede, senza porsi troppe domande. L’architrave di tutto è Sly. Senza di lui una serie così sarebbe una come tante. Lui assolda nuovi soci, improbabilissimi come compari di malefatte, come il ragazzo che gli farà da autista, il gestore di una fumeria legale e li porta allo scontro con una gang locale di motociclisti (una scialba copia dei Sons of Anrachy). Sly discetta su com’era il passato e com’è l’oggi, ha un’avventura, quasi due, e alla donna con cui fa sesso (che poi non è quello che sembra, ma almeno questo lo taccio), che pensa di avere a che fare con un cinquantenne stagionato, confessa candidamente di avere 75 anni e lei si spaventa. Ma poi è lei stessa a cercarlo, a interessarsi a lui. Sì, perché, quando Stallone non è in scena, c’è qualcuno che parla di lui, indaga, trama o si chiede chi sia quest’uomo comparso dal nulla. Ma non si creda che sia solo una visione buonista ed edulcorata del vecchio gangster che parla dei bei vecchi tempi andati; no perché, quando c’è da agire, il generale non è di certo uno che ci va per il sottile e lo si vede chiaramente in due momenti, uno dei quali lo riavvicinerà alla figlia, che fino allora aveva cercato di evitarlo e poi nell’inevitabile scontro coi bikers. La consiglio caldamente, non solo agli amanti del genere e di Sly, perché ci sono anche momenti parecchio divertenti. La serie, 9 episodi, si trova su Paramount + o con particolari giri di abbonamenti tra sky e altre piattaforme.
FUBAR
La serie di Swarzenegger è invece di genere spionistico. Richiama alla memoria uno dei suoi film più riusciti, “True lies” con Jamie Lee Curtis. In quel film Swarzy era uno spietato agente della CIA, che teneva nascosta a sua moglie la sua vera occupazione, fino a dovergliela poi rivelare e coinvolgerla in azioni adrenaliniche e pericolose. Luke Brunner (Swarzenegger) è un agente della CIA, che sta per andare in pensione a 65 anni (se ne toglie una decina, è un po’ meno sincero di Sly), con l’intento di godersi la vita e di cercare di riconquistare la moglie, che crede che il suo lavoro sia il rappresentante di materiale per palestre, dalla quale ha divorziato qualche anno prima, a causa del fatto che si sentiva trascurata. Sembra tutto pronto per il suo commiato dall’agenzia, ma gli viene chiesto di svolgere un’ultima missione, durante la quale la CIA decide, per necessità, di svelare un segreto che fino allora Brunner ignorava. Sua figlia Emma è anch’essa un’agente della CIA (e anche lei non sapeva del padre). Anche questo è mostrato dal primo trailer ed è l’inizio del primo episodio. Da quel momento in poi si accende una dinamica tra i due personaggi, un conflitto generazionale fatto di amore e odio, incomprensioni e voglia di riscatto davvero davvero interessante. Nonostante il tono resti abbastanza leggero (ci sono comunque molte scene action, ammazzamenti, esplosioni e tutto quanto prevede il repertorio, ma in modo non troppo pesante), FUBAR come acronimo ha un significato tutt’altro che divertente. Creato dai soldati americani, divenne (tristemente) noto durante il secondo conflitto mondiale come sigla di Fucked Up Beyond All Repair/Recognition, che si può tradurre con “Fregati oltre ogni possibilità di recupero”. Ed è la situazione in cui si trovano spesso e volentieri i protagonisti di questa serie. C’è da dire che in questo caso i personaggi secondari sono molto ben tratteggiati, sia quelli che fanno parte della squadra, sia i componenti della famiglia (la ex moglie di Swarzy e suo figlio) e della quotidianità dei Brunner, al di fuori delle loro missioni, come il fidanzato di Emma o anche l’attuale compagno della ex moglie di Luke. Questo comporta che Swarzy, pur essendo il protagonista, risulti meno “invadente” e strabordante e che la serie risulti ben strutturata anche grazie ai rapporti che i vari personaggi instaurano fra di loro. Si trova su Netflix ed è suddivisa in 8 episodi.
Qual è la migliore quindi? Beh, innanzi tutto, entrambe finiscono con un bel cliffhanger che presuppone una seconda stagione. Io consiglierei, se possibile, di guardarle tutte e due, sono visioni piacevoli e di grande intrattenimento. Se dovessi per forza dare un giudizio, direi che, come serie, FUBAR è migliore, perché più strutturata, bilanciata nei ruoli e, per assurdo… più verosimile, o forse sarebbe meglio dire meno inverosimile. D’altro canto, l’interpretazione di Stallone come mafioso ex carcerato è una chicca da non perdere.