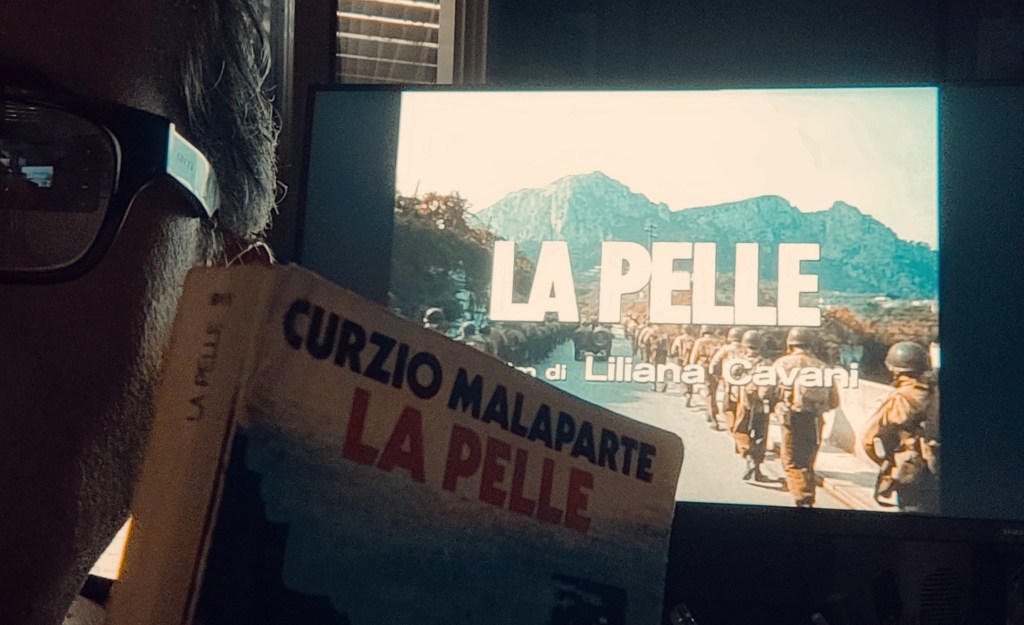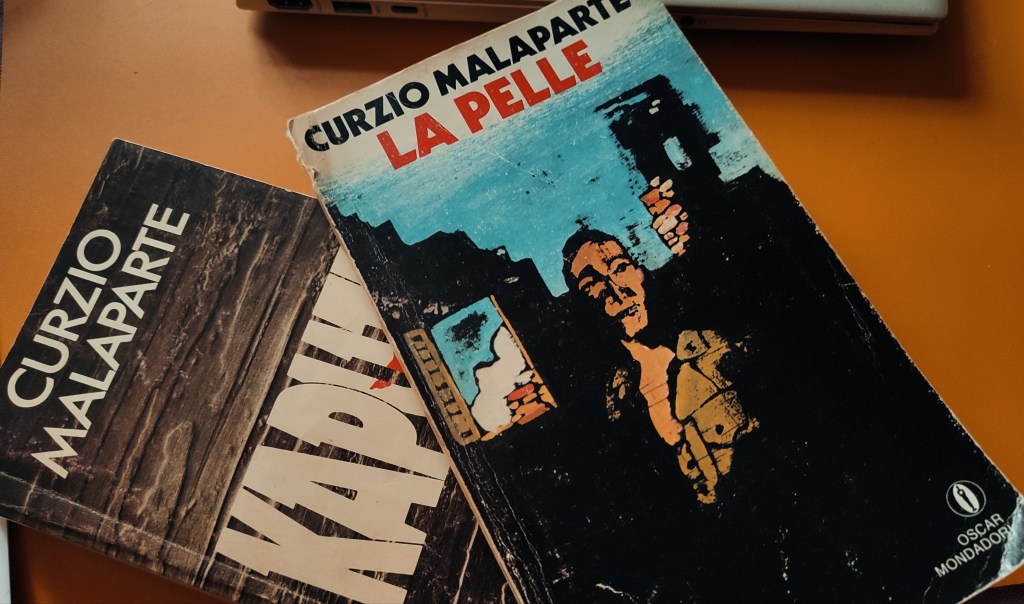Un libro uscito nel secondo dopoguerra che mantiene vivo e fresco il suo messaggio di denuncia contro le ingiustizie del colonialismo e le interpreta da dentro la coscienza del suo protagonista.
Quando si parla di Premio Strega, il pensiero vola al più autorevole riconoscimento per la letteratura italiana. Ma allo stesso tempo, però, spesso si tende a evidenziare quanto tale premio metta in mostra scrittori “già arrivati” (beh, non è un concorso per aspiranti scrittori, ovvio), magari ammanicati con un certo tipo di ambiente (non a caso le candidature arrivano tramite segnalazioni “amiche”, ma il sistema è ampio e complesso e non è mia intenzione voler contestare nulla), e si sottintende pure che dia largo spazio principalmente a un tipo di una letteratura in qualche modo di tendenza o iper intellettualoide, distaccata da quello che non solo è il gusto del pubblico (il che non sarebbe neanche male, quando si parla di gusto di massa), ma anche e soprattutto, lontana da un modo di raccontare che colga in modo acuto e puntuale il vissuto contemporaneo. Questi dubbi possono trovare alcuni riscontri reali, ma è anche vero che non sempre i titoli premiati siano libri pompati ad arte. Dallo Strega emergono non raramente perle destinate a diventare libri importanti, che si rivelano tali indipendentemente dal conseguimento del premio.

Uno dei casi più virtuosi è rappresentato dal primo romanzo premiato dallo Strega (1947), Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Primo e unico romanzo di Flaiano, venne scritto su esplicita richiesta dell’editore Longanesi, il quale poi corteggiò per anni lo scrittore per fargli scrivere altro (tipo un racconto lungo tratto dalla sceneggiatura del film “I Vitelloni” di Fellini, di cui Flaiano era autore), ma non fu mai concesso il bis. Flaiano scrisse per il cinema, fu un acuto critico teatrale e letterario, noto per il suo stile ironico e satirico. La sua produzione letteraria comprende racconti, aforismi e testi teatrali, nei quali spesso emerge una visione disincantata della società borghese italiana.
Tempo di uccidere è quindi un unicum e, provenendo da una penna così arguta, non poteva che essere qualcosa di assolutamente originale. C’è da dire che Flaiano non ne fu mai completamente soddisfatto, non ne capiva le critiche (specialmente quelle positive), era stupito di avere ricevuto un premio tanto importante e sostanzialmente considerava il suo romanzo quasi tutto “da riscrivere”.
Il romanzo è ambientato durante la guerra d’Etiopia (1935-1936), un conflitto voluto dal regime fascista per espandere l’impero coloniale italiano. La campagna militare fu caratterizzata da una pesante repressione delle popolazioni locali e dall’uso di armi chimiche, suscitando condanne internazionali. Flaiano partecipò al conflitto come sottotenente del Genio, un’esperienza che influenzò profondamente la sua visione del colonialismo e che ispirò la stesura del libro. La sua però non è un’opera neorealista, il dramma vissuto dal protagonista è esistenziale e a tratti allucinato e allucinogeno, in qualche modo. L’intento non è nemmeno di offrire uno sguardo politico (il regime fascista non è praticamente mai nominato), magari tendendo a immaginarsi una possibile giustizia sociale o morale. Niente di tutto questo. Il protagonista, un tenete dell’esercito italiano, compie una serie di gesti efferati e scellerati, forte del fatto di trovarsi fuori dalla portata di leggi che nel suo Paese lo avrebbero sicuramente punito e, pur provando un pungente senso di colpa, tende immancabilmente ad autogiustificarsi. Il punto di vista è fortemente immersivo (non sappiamo nemmeno il nome del protagonista), tanto che alle volte il piano del mondo interiore del tenente rischia di confondersi col mondo esterno, reale, o quasi, perché a volte viene ridotto, volutamente, alla stregua di un teatrino.
La trama, in breve: un tenente italiano, durante una missione in Etiopia, uccide accidentalmente una giovane donna indigena. La ferisce prima per sbaglio, dopo aver fatto sesso con lei (e qui già capire quanto il rapporto sia consensuale non è semplice -siamo nella testa di lui), colpendola di rimbalzo con una pallottola indirizzata contro un animale feroce; e poi, constatato che la ferita non è curabile, la finisce con un altro colpo e ne occulta il cadavere. Questo evento innesca una spirale di paranoia, senso di colpa e delirio. L’ufficiale teme di aver contratto la lebbra e si convince di essere perseguitato, riflettendo sul significato della sua azione e sull’assurdità della guerra. La narrazione è in prima persona, con uno stile che mescola realismo e onirismo, creando un’atmosfera claustrofobica e inquietante. Il tenente cercherà di far ritorno in Italia, ma non sarà per nulla semplice. Incontrerà sulla sua strada una serie di personaggi bislacchi, alcuni intenti a trarre da quel soggiorno forzato ogni minimo possibile piacere e altri del tutto impegnati a cercare di arricchirsi, rubando il più possibile e dandosi al contrabbando. Al protagonista preme di scoprire se abbia davvero contratto una brutta malattia e che il suo delitto non venga mai scoperto. Vagheggiando di che cosa dovrà dire o scrivere (nel caso la sua malattia si rivelasse mortale) alla moglie che lo aspetta a casa, il tenente coltiva anche la speranza di tornare da lei e riprendere tranquillamente la vita coniugale, come se nulla fosse mai successo. Ma anche rileggendo le lettere di lei, rimane difficile poter ignorare quanto è successo. Oltre all’ossessione, al senso di colpa e all’alienazione che potrebbe minarne la sanità mentale, l’agire (e il ragionare) dell’uomo sono lo specchio di quanto l’autore ritenesse insensato e brutale il colonialismo italiano; recarsi in un posto dove chi ci abita è considerato un essere di livello inferiore, un selvaggio da assoggettare a proprio vantaggio e per i propri capricci. Il livello di “immersività” è talmente coinvolgente che qualcuno, tra i critici di allora, ipotizzò che il romanzo non fosse altro che un diario personale di Flaiano (bravo lo scrittore, avventato, se non sprovveduto, il critico).
Già all’inizio degli anni Cinquanta il regista Jules Dassin si candidò per trarre un film dal romanzo e propose che la conclusione virasse sul drammatico. Flaiano rispose così:
“Nel mio libro la conclusione drammatica è questa: il protagonista, alla fine, ha di nuovo il sospetto di non essere guarito. Forse non si tratta più della lebbra, si tratta di un male più sottile e invincibile ancora, quello che ci procuriamo quando l’esperienza ci porta a scoprire quello che noi siamo veramente. Io credo che questo non sia soltanto drammatico, ma addirittura tragico.”
Un film tratto dal romanzo venne poi realizzato da Giuliano Montaldo 1989, ma sinceramente non è un granché. Il regista si sforza di riprodurre un acquarello dell’ambientazione africana, anche grazie alla preziosa colonna sonora di Ennio Morricone, ma non riesce minimamente a trasmettere tutto il mondo interiore del protagonista, interpretato da un giovane, biondo e totalmente fuori parte Nicolas Cage, che si atteggia a eroe tragico e parla in perfetto doppiaggese. Nonostante comprimari come Ricky Tognazzi e Giancarlo Giannini, che fanno onestamente la loro parte, e nonostante Cage sia doppiato dalla bella voce di Claudio Sorrentino (voce italiana ricorrente di Mel Gibson, John Travolta e Bruce Willis, oltre all’indimenticabile Ricky Cunningham/Ron Howard in Happy Days), il suo personaggio non c’entra nulla con quello del libro. Erano ancora lontani i tempi in cui a Cage avrebbero appioppato un mandolino in mano per farlo sembrare un soldato italiano più verosimile.

L’opera di Ennio Flaiano rimane un esempio significativo di letteratura impegnata, capace di interrogare la coscienza collettiva e di denunciare le ingiustizie storiche con uno stile unico, penetrante e molto attuale.
Manco a dirlo, lettura fortemente consigliata.